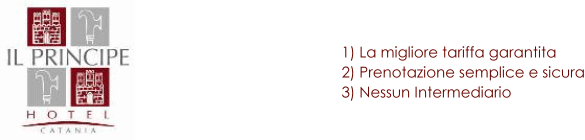|
Probabilmente era un'insediamento d’origine
sicula. La città di Katane (gr. Kατάvη) fu
fondata, secondo il racconto di Tucidide
nella sua "Guerra del Peloponneso" dai greci
calcidesi guidati da Tucle e salpati da
Naxos, nel quinto anno dopo la fondazione di
Siracusa. Avendo scacciato con le armi i
Siculi, fondarono Lentini e dopo Katane. I
nuovi abitanti di Catania elessero come loro
ecista Evarco. Quindi, secondo Tucidide,
Catania fu fondata tra il 729 e il 728 a.C.
da coloni greci provenienti dalla città
Calcide, nell'Eubea (Tucidide, VI 3, 3).
L'abitato arcaico doveva occupare una
collina ben difendibile, immediatamente a
ovest del centro della città moderna, in
coincidenza dell’antico rione Montevergine,
di piazza Dante e dell’ex convento dei
Benedettini (scavi del 1978). Sappiamo
pochissimo sul primo periodo della sua
storia: praticamente solo la notizia
sull'origine catanese del celebre
legislatore Caronda, che poi fu esiliato e
si trasferì a Reggio (Aristotele,
Politica, II 1274a). Vi avrebbero
soggiornato numerosi e celebri uomini di
cultura, come il filosofo Senofane da
Colofone (tra i fondatori della scuola
eleatica) e i poeti Ibico e Stesicoro, che
vi morì (la sua tomba era indicata presso la
principale porta a nord della città, che da
lui prese il nome di porta Stesicorea).
Nel 476 a. C. Ierone, tiranno di Siracusa,
ne deportò gli abitanti a Leontinoi, e li
sostituì con 10.000 nuovi abitanti, in parte
Siracusani, in parte peloponnesiaci, e data
ad amministrare a suo figlio Dinomene
(Diodoro, XI 49, 1 sgg.). Anche il nome
della città venne modificato in Aitna
(Etna): con tale nome è celebrata nella
Pitica I di Pindaro, scritta in onore di
Ierone, e nella tragedia perduta di Eschilo,
rappresentata per l'occasione (Le Etnee). Ma
solo pochi anni più tardi, dopo la morte di
Ierone, Ducezio insieme ai Siracusani
costrinse i nuovi abitanti a trasferirsi a
Inessa (che assunse allora a sua volta il
nome di Etna), centro forse corrispondente
alla Civita di Paternò. Dal 461 Catania
recuperò così il suo nome e i suoi antichi
abitanti (Diodoro, XI 76, 3; Strabone, VI 2,
3).
Durante la guerra tra Siracusa e Atene,
Catania, inizialmente neutrale, prese poi
posizione a favore di Atene, dopo un
celebre discorso che Alcibiade avrebbe
pronunciato davanti all'assemblea riunita
nel teatro della città (Tucidide, VI 50, 3
sgg.; Frontino, Strateg. III 2, 6).
Sottoposta per questo a un'offensiva di
Siracusa, dopo la sconfitta degli Ateniesi
fu salvata dall'invasione cartaginese della
Sicilia del 409 a. C. Ma poco dopo il 403 a.
C. Dionigi di Siracusa riuscì a
conquistarla, e ne vendette in parte come
schiavi gli abitanti. I superstiti si
rifugiarono in un primo tempo a Milazzo, ma
da qui poi furono espulsi, e si dispersero
in varie località della Sicilia. Dionigi
ripopolò la città con i suoi mercenari
campani (Diodoro, XIV 15, 1 sgg.; 58, 2; 87,
1-3). Nel 345 è tiranno di Catania il
sabellico Mamerco, che in un primo tempo si
allea con Timoleonte, ma successivamente
passa ai Cartaginesi (Diodoro, XVI 69, 4).
Sconfitto da Timoleonte nel 338, egli si
rifugerà à Messina, ma, caduto nelle mani
dei Siracusani, verrà crocifisso, dopo aver
subito un processo nel teatro di Siracusa
(Plutarco, Vita di Timoleonte, 30; 31; 34).
Nel 263, all'inizio della prima guerra
punica, Catania (lat. Catĭna o Catăna) viene
conquistata dai Romani, sotto il comando del
console M. Valerio Messalla (Eutropio, II
19). Del bottino faceva parte un orologio
solare che fu collocato nel Comitium a Roma
(Plinio il Vecchio, Naturalis historia, VII
214). Da allora la città fece parte di
quelle soggette al pagamento di un'imposta a
Roma (civitas decumana). Sappiamo che il
conquistatore di Siracusa, Marcello, vi
costruì un ginnasio (Plutarco, Vita di
Marcello, 30).
Intorno al 135 a.C., nel corso della prima
guerra servile, fu conquistata dagli schiavi
ribelli (Strabone, VI 2, 6), e nel 122 a.C.,
a seguito dell’attività vulcanica dell’Etna,
fu fortemente danneggiata dalle ceneri
vulcaniche stesse piovute sui tetti della
città che crollarono sotto il peso. (Orosio,
V 13, 3).
Il territorio di Catina, dopo essere stato
nuovamente interessato dalle attività
eruttive del 50, del 44, del 36 e in fine
dalla disastrosa colata lavica del 32 a.C.
che rovinò campagne e città etnee, e dai
fatti della disastrosa guerra che aveva
visto la Sicilia terreno di scontro fra
Ottaviano e Sesto Pompeo, si avvia sulla
lunga e faticosa strada della ripresa
socio-economica già in epoca augustea.
Tutta la Sicilia alla fine della guerra
viene descritta come gravemente danneggiata,
impoverita e spopolata in diverse zone. Nel
libro VI di Strabone in particolare si
accenna alle rovine subite dalle città di
Syrakusæ, Katane e Kentoripa.
Dopo la guerra contro Sesto Pompeo, Augusto
vi dedusse una colonia. Plinio il Vecchio
annovera la città che i romani chiamano
Catina fra quelle che Augusto dal 21 a.C.
eleva al rango di colonie romane assieme a
Syracusæ e Thermæ (Sciacca). Solo nelle
città che avevano ricevuto il nuovo status
di colonia furono insediati gruppi di
veterani dell’esercito romano. La nuova
situazione demografica certamente contribuì
a cambiare quello che era stato, fino ad
allora, lo stile di vita municipale a favore
della nuova “classe media”.
Nonostante questi continui disastri, che
costituiscono una delle costanti della sua
storia, Catania conservò una notevole
importanza e ricchezza nel corso della tarda
repubblica e dell'impero: Cicerone la
definisce «ricchissima » (Verrine, II 3,
10), e tale dovette restare anche nel corso
del tardo impero e nel periodo bizantino,
come si deduce dalle fonti letterarie e dai
numerosi monumenti contemporanei, che ne
fanno un caso quasi unico in Sicilia. Le
grandi città costiere come Catina, nel corso
del medio-impero, estesero il loro
controllo, anche a fini esattoriali dello "stipendium",
su un vasto territorio nell’entroterra
dell’isola che si andava spopolando a causa
della conduzione latifondistica della
produzione agricola.
Il cristianesimo vi si diffuse rapidamente;
tra i suoi martiri, durante le persecuzioni
di Decio e di Diocleziano, primeggia Sant'Agata,
patrona della città e Sant'Euplio.
Le incursioni barbariche della seconda metà
del V secolo sconvolgono tutta la Sicilia e
quindi anche Catania. Particolarmente
critico sembra essere stato il passaggio dei
Vandali di Genserico negli anni 440 e 441
d.C. provenienti da Cartagine che causò
danni talmente gravi da indurre le autorità
alla remissione del pagamento dei tributi .
Nel 476, Genserico cede ad Odoacre, re degli
Eruli, la Sicilia in cambio di un tributo.
Teodorico, divenuto re degli Ostrogoti nel
474, dopo aver sconfitto più volte Odoacre
in Italia lo uccise nel 493 restando così
l’incontrastato padrone d’Italia. Il
generare bizantino Belisario inviato da
Giustiniano a riconquistare l’Italia occupa
con facilità la Sicilia nel 535. Nuovi
scontri fra Belisario e gli Ostrogoti di
Totila si verificano fra il 542 e il 548
anno in cui il generale bizantino viene
richiamato a Costantinopoli. Catania viene
di nuovo occupata da Totila nel 550, ma dopo
la sconfitta degli Ostrogoti in Umbria e la
morte di Totila nel 552, tutta la Sicilia
tornò sotto il controllo bizantino nel 555.
Fu proprio da Catania che ebbe inizio la
riconquista bizantina dell'isola (Procopio,
Bellum Gothicum, III 40), e in essa ebbe
sede probabilmente il governatore civile
bizantino (praetor o praefectus).
La diocesi di Catania, è accertata fin dal
6° secolo. Rimase bizantina sino alla
conquista araba (sec. 9°).
I Normanni o meglio Ruggero d’Altavilla (Hauteville-le-Guichard),
ultimogenito di Tancredi d’Altavilla,
assieme ai suoi fanti e cavalieri
“cattolici” professionisti della guerra,
provenienti dal ducato di Normandia (Francia
del nord) e che poco avevano a che fare con
i loro “barbari” antenati vichinghi (fase
storica tra 7° e 9° sec.), misero piede in
Sicilia nel 1060. Dopo aver conquistato
Cerami, Troina, Palermo ed altre città, si
impadronirono di Catania nel 1072 che ebbe
un periodo di rinnovato splendore sotto la
guida del vescovo benedettino Ansgerio (Ansgar)
voluto dallo stesso Gran Conte Ruggero.
Gli Svevi, o meglio la dinastia degli
Hohenstaufen, presero il potere in Sicilia
grazie ad matrimonio fra Costanza d’Altavilla,
figlia di Ruggero II d'Altavilla con Enrico
VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa.
Morto il giovane Guglielmo III, ultimo re
del regno di Sicilia e prigioniero in
Germania, Enrico VI rivendicò l’Italia
meridionale e la Sicilia. Nel 1194 e nel
1197 Catania, che aveva sostenuto Tancredi
d’Altavilla prima e poi osato ribellarsi
agli Svevi, fu saccheggiata dalle truppe
germaniche.
La nobiltà cittadina non ebbe un rapporto
felice con gli Hohenstaufen; nemmeno con il
grande Fedrico II di Svevia al quale si
ribellò nel 1232. L’astio verso il potere
imperiale fece nascere diverse leggende tra
le quali quella che vuole che il castello
Ursino sia stato voluto da Federico II per
tenere a bada la popolazione. Avvenimento
importante per il futuro della città fu
l’inserimento di Catania tra le città
demaniali. Finiva così la totale egemonia
del vescovo-conte.
Alla fine della dinastia degli Hohenstaufen,
nel 1266 la Sicilia venne assegnata dal
Papa, che considerava l’isola patrimonio
della Chiesa, a Carlo d’Angiò; ma il dominio
angioino ebbe breve durata. I catanesi, che
avevano subito ingiustizie, sfruttamenti ed
erano stati danneggiati economicamente dalla
chiusura dei porti della città,
contribuirono validamente al rovesciamento
della “mala signoria”. I più importanti nomi
che animarono la rivolta a Catania furono
quelli di Palmiero, abate di Palermo,
Gualtiero da Caltagirone, Alaimo da Lentini
e il catanese Giovanni da Procida. Quest’ultimo
nel 1280, travestito da monaco, si recò dal
papa Nicolò III, dall’imperatore di Bisanzio
Michele Paleologo e dal re Pietro III
d'Aragona, per chidere: al papa di non
appoggiare Carlo d’Angiò in caso di rivolta;
all’imperatore Michele l’appoggio esterno
contro il nemico comune; e al re d’Aragona
di far valere il suo diritto al trono di
Sicilia in quanto marito di Costanza figlia
di Manfredi, l’ultimo degli Hohenstaufen.
Nel 1282 i moti meglio conosciuti come
“Vespri siciliani” posero fine al dominio
dell’isola da parte della dinastia francese.
Appena scoppiò la rivolta in Sicilia, la
flotta aragonese era già a Palermo e
l’occupazione della città da parte di Pietro
dava così inizio alla dominazione degli
Aragonesi in Sicilia (1282-1410). Catania fu
la sede dell’icoronazione del re aragonese
con il nome di Pietro I di Sicilia, ed
acquistò una posizione di privilegio in
quanto nel corso del 14° sec. venne scelta
spesso come sede del parlamento e dimora
della famiglia reale.
A Pietro III successe, in Aragona il suo
primogenito Alfonso III, e in Sicilia il suo
secondogenito Giacomo che subito, nel 1287,
dovette respingere, con l’aiuto
dell’ammiraglio Ruggero di Lauria, le
rinnovate pretese degli angioini che
avanzavano verso Catania da terra e dal
mare. Alla morte del fratello Alfonso III
d’Aragona, Giacomo prese il suo posto e
lasciò in Sicilia suo fratello Federico come
vicario. Ma la politica di riavvicinamento,
di accordi e di legami matrimoniali con la
casa d’Angiò, caldeggiata anche da papa
Nicolò IV, non piacque ai siciliani che il
15 gennaio 1296 si riunirono in parlamento a
Catania ed elessero loro re il giovane
Federico d’Aragona. Ma Aragonesi e Angioini,
alleati per l’occasione, attaccarono le
difese siciliane che, anche grazie al
tradimento di due catanesi, furono superate
e in particolare a Catania Roberto d’Angiò
prese possesso del castello Ursino dove poco
tempo dopo nacque Luigi futuro re di Napoli.
La guerra, che sembrava essersi conclusa con
al pace di Caltabellotta (1302) che
assegnava la Sicilia a Federico d’Aragona
con il titolo di re di Trinacria, proseguì
nel 1313. Federico, contravvenendo agli
accordi, si confermò re di Sicilia e
proclamò suo erede il figlio Pietro che gli
successe nel 1337. Sarà il figlio di Pietro,
Ludovico che riuscirà a tenere testa sia
alle lotte interne fomentate dalle due
fazioni baronali che alle incursioni del re
di Napoli. Il suo successore, il fratello
Federico III d’Aragona il Semplice, nato a
Catania, dopo varie vicende firmerà la pace
di Catania nel 1372.
Federico lasciò il regno alla figlia
minorenne Maria nata dal matrimonio con
Costanza figlia del re Pietro IV d’Aragona,
affiancata da quattro vicari: Artale Alagona,
Guglielmo Perrotta, Francesco Ventimiglia e
Manfredi Chiaramonte. Artale Alagona scelse
per la giovane regina Maria la residenza del
castello Ursino di Catania, progettando di
darla in sposa a Galeazzo Visconti, duca di
Milano. Ma la fazione capeggiata dai Ventimiglia, baroni d’origine catalana,
volevano che sposasse Martino figlio del
duca di Monteblanc presunto erede del trono
aragonese. Il rapimento di Maria portato a
termine da Gugliemo Raimondo Moncada fece
fallire i progetti del Gran Giustiziere del
regno e permise il matrimonio della regina
con Martino di Monteblanc. Re Martino I dopo
la morte di Maria avvenuta nel 1402 sposò
Bianca erede del trono di Navarra che scelse
di stabilirsi a Catania assieme alla corte.
Ma Martino muore a Cagliari nel 1409 all’età
di 33 anni e a lui succede il vecchio padre
Martino duca di Monteblanc che però morirà
l’anno successivo.
Catania sarà teatro delle traversie avute
dalla regina Bianca a causa delle mire per
la successione al trono da parte del Gran
Giustiziere Bernardo Caprera, conte di
Modica. Con l’elezione di Ferdinando I re
d’Aragona, Valenza e Catalogna la Sicilia fu dichirata provincia del regno aragonese. La
vedova regina Bianca fu confermata
“vicaria”. La Sicilia quindi non è più un
Regno ma solo una provincia e sarà così fino
alla dominazione borbonica. I catanesi si
consolarono con alcuni privilegi concessi
loro dalla regina Bianca.
Il successore di Ferdinando I, [[Alfonso il
Magnanimo riunì il 25 maggio del 1416, nella
sala dei Parlamenti di castello Ursino tutti
i baroni e i prelati dell’Isola per il
giuramento di fedeltà al Sovrano e fino al
30 agosto vi si svolsero gli ultimi atti
della vita politica che videro Catania come
città capitale del regno. Ma fu lo stesso re
Alfonso che permise la nascita a Catania
dell’Università più antica della Sicilia
(1434). Inoltre il 31 maggio del 1421,
invitato da Gualtiero Paternò e Andrea
Castello, che erano stati presenti al
parlamento che il re aveva tenuto a Messina,
venne a Catania per riconfermare
ufficialmente le “libertà” e gli “statuti”
della città.
La Sicilia passa tra i possedimente spagnoli
d’oltre mare e sarà retta da un vicerè che
allontanerà per sempre la diretta conduzione
politico-economica del sovrano. Catania
continuò a essere favorita dai sovrani
spagnoli, ma il popolo partecipò alla
rivolta contro Ugo de Moncada nel 1516 e ai
tumulti del 1647, in odio al fiscalismo
governativo. Una grande colata lavica, le
cui bocche effusive si aprirono a bassa
quota nel territorio del comune di Nicolosi,
investì nel 1669 il lato ovest e sud della
città. I danni alle campagne, alle strade e
alle difese furono molto gravi ma le stesse
mura di difesa della città riuscirono a
impedire, in massima parte, che la lava
entrasse nel centro abitato. Ventidue anni
dopo, nel 1693, un altro disastro colpì
Catania. Un violentissimo terremoto scuote
tutta le Sicilia orientale ma i danni
maggiori si registrano nell’area etnea.
Dopo il terremoto del 1693, la città si
sviluppò sino a occupare uno dei primi posti
nel commercio italiano; nel 1820 non aderì
al moto indipendentista e fu coi
costituzionali napoletani;nel 1837 partecipò
alle rivolte occasionate dal colera, e nel
1848-49 fu all'avanguardia del movimento
autonomista.
Nell'agosto 1862 Garibaldi vi stabilì il
centro organizzativo della spedizione
conclusasi ad Aspromonte.
Durante la seconda guerra mondiale, dopo lo
sbarco anglo-americano in Sicilia (9 luglio
1943), i Tedeschi, dopo aver bloccato il
generale Montgomery al ponte Primosole sul
fiume Simeto, per sottrarsi alla manovra
aggirante degli Anglo-Americani,
persistettero a lungo nella difesa di
Catania, che evacuarono solo il 5 agosto
|